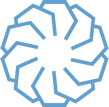Gli impatti ambientali del Mining di Bitcoin: sfide presenti e future
In un mondo sempre più attento all’impatto che le attività umane hanno sia sulla salute sia sull’ambiente, la stima delle emissioni in atmosfera, tra gli altri, del diossido di carbonio (CO₂) è di fondamentale importanza per favorire l’adozione delle necessarie politiche (e azioni) virtuose.
Se da un lato la stragrande maggioranza delle emissioni di gas serra (misurate in termini di tonnellate di CO₂ equivalente, tCO2eq.) sono riconducibili ad attività dei processi produttivi, del trasporto, processi forse meno “visibili” quali il mining di criptovalute come il Bitcoin, producono effetti non trascurabili.
Lo studio sviluppato presso i locali del Tecnopolo di Rimini, da parte dei ricercatori dei Dipartimenti di Chimica Industriale “Toso Montanari” e di Chimica “Giacomo Ciamician”, ha voluto inserirsi nel dibattito sulle emissioni di diossido di carbonio dovuto all’estrazione (mining) di Bitcoin e, perciò, al consumo di elettricità di centri di calcolo appositi, considerando le specifiche fonti di produzione elettriche dei singoli Stati coinvolti.
Un primo dato interessante riguarda la “geografia” di tale mining: 8 Stati a livello mondiale concorrono al 91% dell’attività di “estrazione” di Bitcoin. Tuttavia, i soli Stati Uniti d’America, Cina e Kazakistan sono responsabili del 98% delle emissioni di tCO₂eq. legate a tale attività.
Basandoci sui dati relativi a questi 8 Stati, i calcoli mostrano che nel 2022 una quantità pari a circa 52 milioni di tCO₂eq. (cioè relative alle emissioni derivanti dalle sorgenti elettriche utilizzate) sono state prodotte dalle attività riconducibili al mining di Bitcoin, circa quante le emissioni totali di Singapore nell’anno 2022.
Lo studio ha poi posto l’attenzione verso tre direzioni:
- Formulare proiezioni al 2030 e 2050 di emissioni carboniose in atmosfera considerando la variazione (positiva e negativa) del consumo elettrico legato al mining, e anche la riduzione nell’utilizzo di sorgenti fossili dei singoli Stati presi in esame
- Valutare l’effetto dell’ipotetico recupero di calore generato dai computer che eseguono i complessi calcoli volti a minare i Bitcoin
- Stimare la quantità di sistemi molecolari necessari per la cattura dell’anidride carbonica prodotta per generare l’estrazione di Bitcoin in un anno di riferimento.
I risultati mostrano che un aumento incontrollato dell’elettricità necessaria per le operazioni di mining di Bitcoin annullerebbe i vantaggi derivanti dall’adozione di fonti di energia rinnovabili a discapito di quelle fossili.